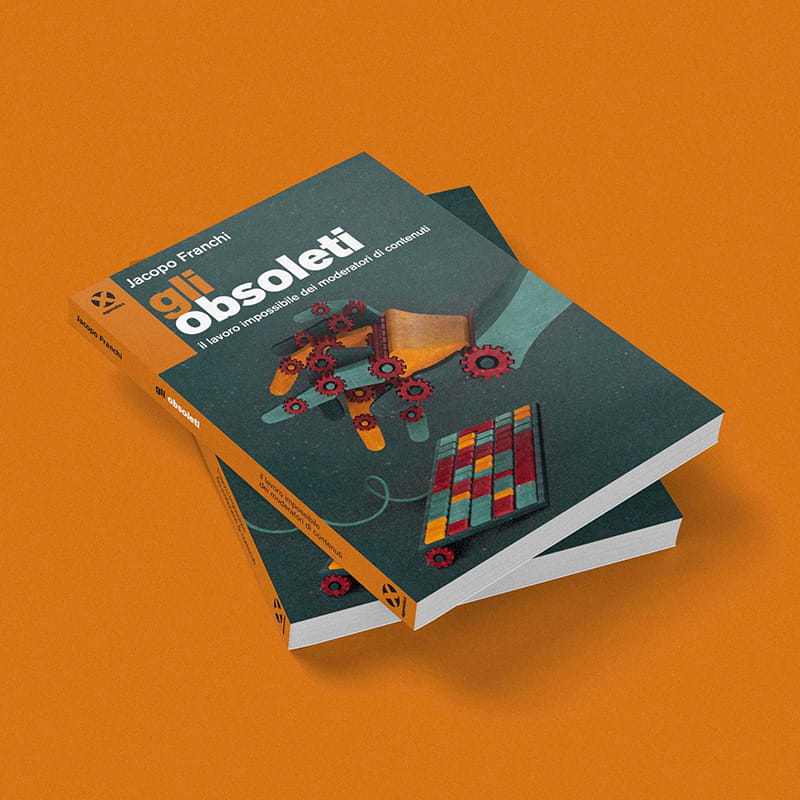Sintesi e commento della decima edizione del Digital News Report, realizzato dal Reuters Institute, sullo stato dell’arte del giornalismo globale per quanto riguarda i modelli di business e il rapporto con i lettori e le piattaforme digitali.
La maggior parte delle persone non vuole pagare per accedere alle notizie, solo una minima parte dei lettori è disposta a sottoscrivere uno o più abbonamenti per sostenere il lavoro dei media e dei giornalisti; gli smartphone sono lo strumento più utilizzato per informarsi ma le app e i siti ufficiali dei giornali e degli altri media sono meno utilizzati di social media e motori di ricerca; Facebook e Twitter rimangono i social dove si consumano più notizie, ma in maniera per lo più involontaria, mentre sulle altre piattaforme la visibilità dei media e dei giornalisti è minima rispetto ad altri contenuti e fonti di intrattenimento; malissimo la carta, in leggera ripresa la televisione, non ancora pienamente sviluppati i podcast; la maggior parte delle persone, a livello globale, vuole che le notizie siano trattate in forma oggettiva e che riportino tutti i punti di vista su un determinato fatto o opinione; giovani, donne, minoranze etniche, persone che vivono al di fuori dei centri metropolitani seguono meno le notizie perché non si sentono adeguatamente rappresentati dai media: questi, in estrema sintesi, sono i risultati della decima edizione del Digital News Report del Reuters Institute sullo stato dell’arte del giornalismo globale in oltre 46 “mercati” analizzati.
Un report di cui non sentirete parlare perché molti media italiani ne escono davvero male dal punto di vista dell’immagine
Il report del Reuters Institute, di oltre 160 pagine, è basato su questionari online somministrati da YouGov tra gennaio e febbraio 2021 con l’aggiunta di focus group, interviste, e schede di approfondimento dedicate ai media di ciascun Paese: per questo motivo la sua stessa diffusione stampa è tutt’altro che scontata perché a parte Ansa, SkyTg 24 e Il Sole 24 Ore, con percentuali di affidabilità superiori al 70% degli utenti intervistati, la maggior parte dei media italiani ne esce piuttosto ridimensionata, con livello di affidabilità percepita ben al di sotto del 70% del totale (è il caso del Fatto Quotidiano, del Giornale, di Libero, di Fanpage). È un’inchiesta sui media ma anche contro il modello rappresentato da certe tipologie di media che nel corso degli anni si sono concentrati ossessivamente sulla crescita del numero di utenti ai propri siti web, a prescindere dalla qualità dell’informazione trattata. Un’inchiesta, dicevo, che dà voce ai fruitori di notizie online – quelli maggiormente raggiunti dai sondaggi di YouGov, per stessa ammissione degli autori del report – e che documenta uno stato di crisi del giornalismo ben più ampio della narrativa autocelebrativa di molti gruppi editoriali storici del nostro e di altri Paesi. Oltre la metà degli utenti intervistati a livello globale (il 56%) dichiara, infatti, di non avere fiducia nel lavoro dei media, anche se la percentuale di coloro che manifestano fiducia è cresciuta di sei punti percentuali nell’anno della pandemia.

Il lavoro dei giornalisti è finanziato da investimenti pubblicitari in contrazione e dal sostegno economico di appena un utente su sei
La scarsa fiducia di cui godono i media a livello globale ha il suo corrispettivo nello scarsissimo successo raggiunto finora dalle iniziative volte a convincere gli utenti a trasformarsi in abbonati paganti e fedeli. Ad oggi, solo il 17% delle persone intervistate dagli autori del Digital News Report dichiara di aver pagato per accedere a delle notizie online nell’ultimo anno (erano il 12% cinque anni fa), poco più di una persona su sei, con Paesi come Francia, Germania e Regno Unito dove gli abbonati non superano l’11% del totale del pubblico potenziale. Oltre l’80% degli utenti intervistati in oltre 20 Paesi, quelli dove gli abbonamenti sono stati attivamente promossi e sono diventati ormai uno standard di mercato, preferisce cercare notizie accessibili gratuitamente o, in molti casi, rinunciare del tutto al consumo di notizie. Ricchi, adulti, anziani e istruiti sono quelli più propensi a sottoscrivere abbonamenti mensili o annuali ai media, solitamente non più di uno o due allo stesso tempo, mentre non sono pochi coloro che non sottoscrivono abbonamenti perché non vogliono limitarsi a seguire solo poche fonti di notizie. Allo scenario drammatico di una continua contrazione degli investimenti pubblicitari, che dai media tradizionali si spostano sempre più sulle piattaforme tecnologiche come Google e Facebook, si aggiunge il fatto che solo un quarto delle persone intervistate si dichiara favorevole al finanziamento pubblico dei media minacciati di sparizione.

Le app dei media e gli aggregatori sono sottoutilizzati dalla maggior parte degli utenti, mentre social media e motori di ricerca fanno da padroni
La disaffezione delle persone nei confronti dei media non è, o non è più, una questione tecnologica o di mancata “comodità” e facilità di accesso all’informazione: se oggi oltre il 70% degli utenti online leggono e si informano tramite lo smartphone, solo il 25% (in calo di tre punti percentuali anno su anno) accede direttamente alle app o siti web dei media tradizionali, mentre il 50% si serve a pari merito di social media e motori di ricerca per cercare o trovare notizie condivise da altri. Poco utilizzati gli aggregatori (a eccezione dei Paesi asiatici) e ancora meno le newsletter che non superano il 5% del pubblico online di potenziali lettori. Negli under 35 l’abitudine ad accedere ad app e siti web sviluppati dagli editori è ancora meno diffusa, con il traffico “diretto” che non supera il 18% del totale e le newsletter che si fermano al 3% nella fascia di età under 35, mentre i social sono il primo canale di accesso alle notizie per il 34% dei giovani e i motori di ricerca arrivano al 26% del totale, pur con importanti differenze da piattaforma a piattaforma. Continua il calo della carta anche nei Paesi in cui l’abitudine alla lettura dei quotidiani e periodici cartacei è resistita più a lungo che altrove, come la Germania (dove si registra il calo dal 38% al 26% anno su anno degli utenti che nella settimana prima dell’intervista hanno acquistato un cartaceo).

(Fonte: Digital News Report del Reuters Institute)
Facebook e Twitter sono ancora le piattaforme di maggior diffusione delle notizie, gli altri social rendono la vita impossibile ai giornalisti
Le piattaforme digitali, tuttavia, non sono tutte uguali quando si tratta di diffondere le notizie: Twitter e Facebook si confermano come gli unici social in cui i media tradizionali e i giornalisti rimangono le principali fonti di news, che gli utenti per lo più non cercano attivamente ma che vedono apparire all’interno dei propri feed di contenuti grazie alla selezione operata da algoritmi, moderatori e fact-checker professionisti. Visibilità e rilevanza dei media e dei giornalisti sono invece ridotte al minimo su piattaforme altrettanto popolari come YouTube, Instagram, Snapchat e TikTok, dove le fonti di notizie principali sono gli influencer, le persone “comuni” e i media cosiddetti “alternativi”: al di fuori di Facebook e Twitter le persone sono meno esposte alle notizie dei media, meno interessate, meno propense a condividerle, e i media stessi che pur hanno stabilito una presenza continuativa su Instagram o TikTok sono tuttora costretti ad adattare le notizie ai format delle piattaforme, con il rischio concreto di una banalizzazione degli argomenti trattati per ottenere in cambio un surplus di interazioni e visibilità attraverso quiz, video umoristici, format video “brevi” ed emozionali. A confronto, le limitazioni di visibilità degli algoritmi di Facebook e Twitter sembrano oggi ben poca cosa rispetto ai limiti ristretti di pubblicazione concessi da piattaforme come Instagram o TikTok ai giornali e giornalisti: un fatto tanto più preoccupante quanto più si considera che è su queste ultime piattaforme che si concentra oggi l’interesse e il tempo degli utenti online, soprattutto dei più giovani.

Sorpresa: il successo dei podcast non è ancora scontato, e neppure la diffusione delle notizie sugli smart speaker
Scarso, finora, l’apporto dei podcast al rilancio del settore: restrizioni dei viaggi e trasporti durante il lockdown hanno rallentato la crescita di una modalità di fruizione delle notizie fino a un anno fa ritenuta di sicuro successo e diffusione globale, ma non si tratta di uno “stop” temporaneo. Ad oggi, meno di un terzo degli utenti dichiara di aver ascoltato almeno un podcast nel corso dell’ultimo mese, in percentuale stabile anno su anno con variazioni minime che oscillano dal 38% della Spagna al 21% del Regno Unito. Si conferma la difficoltà, per le persone, di ricavare sufficiente tempo per l’ascolto e la scoperta di nuovi contenuti: la maggior parte degli utenti si affida ancora oggi ai consigli di amici, familiari e colleghi per scoprire nuovi podcast, tranne in Europa dove la ricerca online è diventata il mezzo predominante, mentre i suggerimenti automatici forniti dagli algoritmi delle piattaforme la pubblicità a pagamento sono tuttora inadeguati a favorire la crescita del settore nel suo insieme e la generazione di ricavi sufficienti a giustificare l’investimento in contenuti audio. Da notare, infine, come solo una minoranza degli utilizzatori degli smart speaker si serva di questi ultimi per seguire le notizie (5% negli USA, 6% nel Regno Unito).

(Fonte: Digital News Report del Reuters Institute)
Giovani, minoranze etniche, utenti non metropolitani non si sentono rappresentati, ma non sono disposti a a sostenere i media locali
I limiti del giornalismo attuale non sono, tuttavia, solo una questione di format, di piattaforme, di modello di business ancora lontano dall’essere consolidato. Dalla ricerca del Reuters Institute emerge con chiarezza come una parte degli utenti oggi non si senta rappresentata, o si senta mal rappresentata, dai media in generale: si tratta dei giovani, delle minoranze etniche, di alcuni gruppi politici e di coloro che vivono al di fuori delle città e dei grandi centri metropolitani o di potere, come avviene ad esempio nelle aree interne degli Usa, nelle regioni settentrionali del Regno Unito e nei lander orientali della Germania. Eppure, la scarsa attenzione dei grandi gruppi editoriali e dei media “mainstream” nei confronti di segmenti rilevanti del proprio pubblico non ha come conseguenza quella di un maggiore interesse di quest’ultimo verso media cosiddetti specializzati o locali: in particolare la crisi dei media locali sembra essere oggi quella con minori margini di miglioramento, dal momento che un numero sempre più ampio di notizie che un tempo erano di competenze di quotidiani, radio e tv locali sono oggi fornite da app, motori di ricerca e social media (come le notizie sul meteo, sugli eventi, sull’attività dei politici locali che tendono sempre più spesso a disintermediare i giornalisti attraverso le piattaforme digitali).

(Fonte: Digital News Report del Reuters Institute)
La maggioranza degli utenti vuole giudicare in autonomia, senza alcun filtro operato dai media nei confronti della diversità di opinioni
In questo senso, è importante qui ricordare come oltre il 70% degli utenti intervistati per il report del Reuters Institute si dichiari a favore di un’informazione quanto più possibile neutrale e pluralista: contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a pensare da certi allarmi ripetuti sulla polarizzazione delle opinioni e del dibattito pubblico, la maggior parte delle persone pretende dai media un lavoro di raccolta e di messa a confronto delle opinioni con l’obiettivo di farsi una propria idea in autonomia su eventi e fenomeni di rilevanza pubblica. Nella maggioranza dei casi non viene richiesto ai media di farsi portavoce di cause sociali, non viene chiesto di censurare opinioni prive di valore scientifico o non sufficientemente autorevoli, e neppure di esprimere il punto di vista di un determinato partito, movimento o ideologia politica. Se è vero che il 21% dei più giovani ritiene che i media debbano in qualche modo operare da filtro su alcune opinioni e dichiarazioni pubbliche, soprattutto su argomenti particolarmente sensibili e complessi come le pandemie o il cambiamento climatico, la maggior parte di coloro che sono interessati a leggere, ascoltare o vedere le notizie vogliono essere messi nelle condizioni di poter valutare di volta in volta l’opinione più credibile e autorevole, con una buona dose di fiducia nella propria capacità di essere in grado di distinguere il vero dal falso, ciò che è rilevante da ciò che non lo è, i fatti reali dal rumore di fondo che gli stessi media, con la loro disperata lotta per la sopravvivenza, contribuiscono non poco ad amplificare.