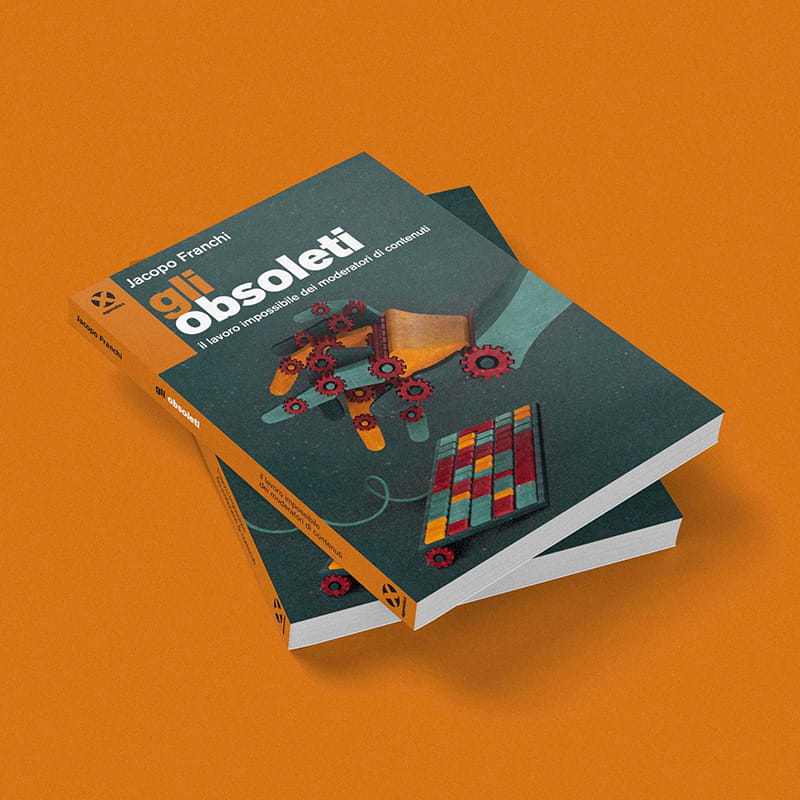Nella prima campagna elettorale in cui dopo anni è mancato il confronto televisivo tra i leader, i social media sono stati usati in maniera per lo più antiquata e conservatrice, anche da chi avrebbe dovuto più degli altri cercare un modo per recuperare voti.
Lo spot di Renzi in bicicletta, il concorso “Vinci Salvini”, l’ingresso di Berlusconi nell’eternità digitale, e la diretta Facebook di due ore con cui Di Maio ha presentato la squadra di governo due giorni prima delle elezioni. In una campagna elettorale priva di confronti televisivi tra i leader, i social media hanno rappresentato il primo canale di comunicazione per i partiti in corsa alle elezioni 2018, anche in virtù della scarsità di fondi con cui finanziare campagne elettorali tradizionali, e al timore di fare figuracce nel misurarsi di fronte a piazze troppo grandi e troppo vuote rispetto al passato.
Diventati canali di comunicazione imprescindibili, per cause di forza maggiore, i social media tuttavia sono stati usati dai leader secondo una stessa, identica strategia, seppur declinata in contenuti differenti da candidato a candidato: una pagina pubblica, da cui far partire in ogni direzione e attraverso campagne a pagamento contenuti che avrebbero dovuto coinvolgere fasce differenti di pubblico. Nessuno, nemmeno chi avrebbe dovuto recuperare voti, ha provato qualcosa di diverso, usando i social media per raggiungere gli indecisi e costringere gli avversari al dibattito. Alla vecchia maniera, ma con strumenti nuovi.
L’incertezza delle analisi quantitative e di sentiment
Difficile, come al solito, giudicare quanti e quali voti i social media abbiano contribuito a smuovere da una parte all’altra. L’impossibilità di accedere ai dati completi delle audience raggiunte, delle interazioni di secondo livello e successivi, dei budget spesi in post sponsorizzati rende ogni analisi quantitativa niente più che un’induzione. Le stesse misurazioni del sentiment della Rete lasciano il tempo che trovano, se non sono accompagnate da una precisa differenziazione tra post pubblicati da uomini e post pubblicati da bot, e tra commentatori abituali ed estemporanei. Come ricordato dal professor Edoardo Novelli su Linkiesta, ognuno di noi ha visto una campagna elettorale differente sui social e nessuno, nemmeno le agenzie di social media intelligence, dispone di una visione d’insieme o scientificamente attendibile per poterne trarre conclusioni affidabili.
Il prevalere dei leader sui partiti
È stata la campagna dei leader, con le pagine di Matteo Salvini (2 milioni di fan), Luigi di Maio (1,3 milioni) Matteo Renzi (1,1 milione di fan) e Silvio Berlusconi (1 milione) di gran lunga più seguite e commentate di quelle dei loro stessi partiti (solo la pagina dei 5 Stelle supera di poco il milione di fan). A far notizia sono stati loro, i leader, con le loro dichiarazioni, le loro foto e le inevitabili gaffe. Ognuno seguendo un copione diverso, dalle fake news ai migranti, dagli inviti alla ragionevolezza a quelli alle “spallate”, ma tutti allo stesso modo concentrati a motivare le proprie truppe di sostenitori e differenziarsi quanto più possibile dagli avversari. Senza mai cercare, tuttavia, lo scontro diretto: tutt’al più un riferimento in un post sulla propria pagina, una sfida al confronto lanciata in differita e a cui nessuno si attendeva risposta.
L’illusione delle campagne “mirate”
Per partiti costretti a fare i conti con casse sempre più vuote, nella prima campagna elettorale in cui mancheranno anche i rimborsi pubblici su cui avevano fatto finora affidamento, i social media rappresentano un canale relativamente più economico per raggiungere ampie fasce di popolazione. In maniera, dicono giornalisti ed esperti più o meno noti, “mirata” e selettiva, grazie alla possibilità di poter promuovere a pagamento i singoli post e tweet verso un pubblico definito in base a categorie demografiche e di “interessi”, stabiliti dagli stessi social media.
Chi dei social ha fatto una professione, tuttavia, sa bene quanto sia difficile definire un pubblico per le campagne a pagamento, e quanto le metriche di misurazione dei social siano incomplete e spesso fuorvianti. È possibile far vedere un post che parla di incentivi alla formazione e sgravi contributivi ai neoassunti a un numero elevato di giovani, di sesso maschile, che vivono stabilmente a Milano: tutt’altra cosa è distinguere grazie ai social chi tra quei giovani è effettivamente occupato, disoccupato, “Neet”, o non ha neppure il diploma. Il social non è in grado, o non consente di mostrare distinzioni di questo tipo all’interno del pubblico scelto come “target”.
Una strategia (troppo) conservativa
Dando per scontata la presenza di una massa sempre più consistente e ritenuta (a torto) irrecuperabile di astensionisti, i leader hanno concentrato tutte le proprie energie e risorse economiche per consolidare la propria base elettorale, guadagnare maggiore visibilità grazie alle interazioni spontanee dei fan ed evitare, per quanto possibile, il peggio (o l’irrilevanza, come nel caso di Grasso, fermo a 140 mila fan). Nessuno, tuttavia, ha pensato di usare i social media per quello che davvero queste piattaforme offrono di innovativo rispetto alla televisione e ai giornali: la disintermediazione, la possibilità di essere ovunque e di dialogare con chiunque, in qualunque luogo e in qualunque momento del giorno. Senza aspettare che l’altro accetti il dibattito, ma cercandolo attivamente, nel momento e nelle circostanze meno prevedibili.
Usare i social media per cercare il dibattito negato in televisione
Affidandosi alle campagne pubblicitarie a pagamento e agli “esperti” dei social, i leader politici hanno rinunciato in partenza a usare i social media come strumento per andare al di fuori del ridotto ambito del proprio elettorato, per cercare attivamente il dibattito su quelle pagine e in quei gruppi popolati da elettori indecisi o addirittura di orientamento opposto. Nessun leader, a quanto mi risulti, ha provato a usare la propria pagina pubblica per pubblicare un commento sotto i post della pagina di un avversario, e costringerlo così ad accettare (o a sfuggire palesemente) un dibattito da cui avrebbe potuto forse uscire vincitore, agli occhi della maggioranza degli osservatori. Non lo hanno fatto né quelli che erano in vantaggio, né tantomeno quelli che avrebbero dovuto usare i social per recuperare qualche voto in più.
I leader di questa campagna elettorale si sono forse troppo facilmente compiaciuti chi del proprio milione, chi del milione e mezzo, chi dei due milioni di fan, ignorando la regola basilare dei social media (e di Facebook soprattutto), per cui all’aumentare del numero di fan diminuisce anche la visibilità media dei propri post. Incapaci di uscire dalla propria pagina pubblica, se ne sono fatti imprigionare, senza pensare nemmeno per un secondo a usare il proprio profilo privato (se ce l’avevano) per andare a cercare il dibattito in quei gruppi Facebook composti da migliaia e migliaia di persone, dalle social street ai gruppi di elettori avversari: piazze forse meno compiacenti, ma di gran lunga più popolose, attive e “reali” di una folla raccogliticcia di target attentamente “selezionati”. È stata la campagna elettorale dei social, più che dei leader in sé, fin troppo solerti a lasciarsi modellare dai format e dalle metriche di quel Facebook in cui hanno investito fino all’ultimo centesimo.