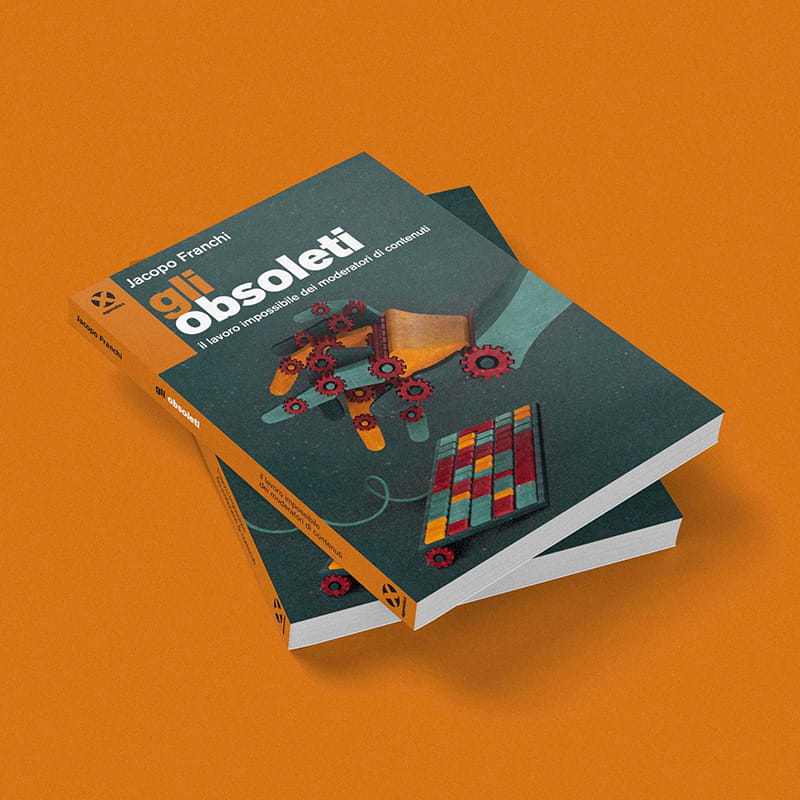Concepito come strumento per limitare la diffusione di contenuti d’odio e razzisti in Rete, il NetzDG tedesco è diventato un modello da imitare negli Stati autoritari, al punto che nella stessa Germania un nuovo emendamento al cosiddetto “Network Enforcement Act” è stato bloccato dal Presidente federale.
Tutti i contenuti d’odio e di incitamento al razzismo devono essere rimossi dalle piattaforme digitali come Facebook e Twitter entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione di una segnalazione proveniente dagli utenti, pena una multa che può arrivare fino a 50 milioni di euro. È questo l’intento perseguito dal Network Enforcement Act, meglio conosciuto come “NetzDG“, la legge fortemente voluta nel 2017 dal ministro della giustizia tedesco Heiko Maas e che obbliga i social media alla rimozione di post e contenuti “evidentemente illegali“: una legge fortemente criticata fin dai suoi esordi e che, come dimostrato in un report, è diventata fonte d’ispirazione per i regimi autoritari di mezzo mondo, prima di essere adottata come modello dal nuovo Digital Services Act europeo.
I ripensamenti della politica tedesca sul NetzDg dopo i sospetti di incostituzionalità
Nel report, pubblicato dal think tank danese “Justitia” e intitolato non a caso “The Digital Berlin Wall”, i ricercatori Jacob Mchangama e Joelle Fiss hanno dimostrato come il NetzDG tedesco sia stato utilizzato come modello di riferimento per rafforzare e in alcuni casi “giustificare” la censura online in numerosi Paesi autoritari: negli ultimi due anni, Paesi come Venezuela, Vietnam, Russia, Bielorussia, Kenya, Singapore, Malesia, Filippine, Turchia, Mali, Cambogia e Pakistan hanno con più o meno successo costretto le aziende come Facebook a censurare preventivamente “fake news”, blasfemie e critiche al governo in carica, in rispetto delle mutevoli leggi locali e non di rado in aperta violazione con i più basilari diritti umani fondamentali.
Chi decide che cosa sia illegale, e che cosa no? Non più i giudici, apparentemente: sono oggi le piattaforme digitali come Facebook a “far rispettare” la severa legge tedesca che punisce e criminalizza qualsiasi manifestazione di razzismo e discriminazione verso altre persone, concepita in seguito ai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. A tutto c’è un limite, tuttavia, anche alla delega di poteri e responsabilità: un emendamento al Network Enforcement Act approvato nel 2020, che avrebbe costretto le piattaforme a segnalare e svelare l’identità gli autori dei contenuti “illegali” alla polizia federale e senza ricorrere al mandato di un tribunale, è stato respinto dal presidente federale tedesco che ha espresso forti dubbi sulla sua costituzionalità.
Il Digital Services Act e lo “scaricabarile” delle istituzioni sulle piattaforme digitali
Due anni di critiche, di dibattiti e ripensamenti non hanno tuttavia impedito al NetzDG di affermarsi come modello di riferimento globale, non più solo tra i regimi autoritari: se in Francia è stata la corte costituzionale a respingere una legge ispirata alla NetzDG tedesca, quest’ultima sarebbe servita da modello per la definizione delle nuove regole di moderazione di contenuti online previste dal “Digital Services Act” della Commissione Europea (fonte: Euractiv). Il “Digital Services Act”, che inizierà il suo iter legislativo a breve e che avrà come scopo quello di ridefinire il framework legale entro cui operano le piattaforme digitali nell’Unione, potrebbe a questo punto estendere all’intero continente un controverso meccanismo fin qui adottato dalla sola Germania.
Nulla di nuovo, purtroppo: l’adozione del Network Enforcement Act a livello comunitario non sarebbe altro che l’ultimo esempio della politica dello “scaricabarile” che i governi più importanti d’Europa hanno fin qui perseguito. Come sottolineato da David Kaye nel suo libro “Speech Police”, infatti, fin dal 2016 le istituzioni europee e i governi nazionali hanno messo sempre più sotto pressione le piattaforme digitali, richiedendo a queste ultime di moltiplicare i propri sforzi per individuare e censurare i contenuti di disinformazione, terrorismo e ora anche di odio e incitamento al razzismo: una strategia ottimale sulla carta, lodevole nelle intenzioni, ma che non prevede alcun tipo di incentivo per compiere indagini più accurate e mantenere online i contenuti che potrebbero non violare la legge, o che potrebbero risultare di interesse pubblico, giornalistico e storico.
I limiti del sistema di moderazione di contenuti privato, e i fantasmi della Germania (e dell’Europa)
La delega alle piattaforme digitali del potere di giudicare e censurare i comportamenti “evidentemente illegali” si scontra con le prerogative costituzionali del potere giudiziario, e con i limiti logistici di qualsiasi sistema di moderazione di contenuti online affidato interamente ad aziende private: il Network Enforcement Act tedesco ha “scaricato” su qualche migliaio di disgraziati e anonimi moderatori di contenuti di Facebook la tremenda responsabilità di distinguere tra odio e sarcasmo, tra espressioni di razzismo ed espressioni di sensibilizzazione contro il razzismo, tra aggressioni gratuite e tentativi mal riusciti di difesa contro l’aggressività altrui, entro tempi strettissimi e che non tengono conto delle possibili variazioni quantitative e qualitative dei contenuti “illegali”.
Un ulteriore limite di questa approccio si colloca nel ruolo fin qui riservato agli utenti delle piattaforme: sono questi ultimi, infatti, che con le loro segnalazioni devono avviare il processo di revisione e censura dei contenuti “illegali”, senza il potere di verificare la correttezza del processo dall’inizio alla fine e senza la possibilità di comunicare direttamente con i moderatori di contenuti. La disponibilità degli utenti a partecipare al “meccanismo” previsto dal NetzDG viene data oggi ingenuamente per scontata, così come viene dato per scontato il fatto che le segnalazioni stesse non possano essere inviate in malafede. Non sorprende, in questo contesto, che uno dei più grandi centri di moderazione di contenuti per Facebook si trovi oggi proprio a Berlino: capitale di una Germania che si interroga sul proprio essere divenuta un modello per i Paesi democratici come per quelli autoritari, mentre lascia che sia un’azienda privata a proteggerla dai suoi fantasmi e dalle sue paure di un ritorno a tempi ben più oscuri.