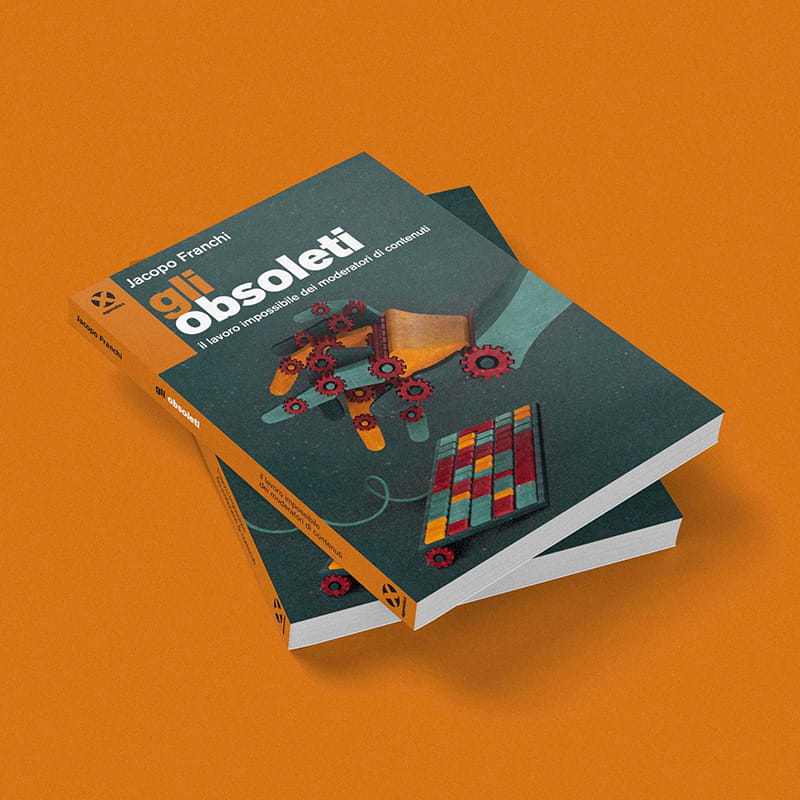Assumerli è facile, dare loro un compito altrettanto, metterli uno di fianco all’altro non pone particolari problemi. Il difficile arriva quando ci si aspetta che dalla loro vicinanza scaturisca quasi spontaneamente un modello di collaborazione da applicare ai diversi ambiti di un’azienda, di una società, di una classe dirigente.
Dopo gli anni “ruggenti” della Silicon Valley di questo primo scorcio di nuovo millennio sta maturando ormai ovunque la consapevolezza che tutte le piccole e grandi aziende (o istituzioni) potrebbero beneficiare dalla collaborazione di umanisti e tecnici più che dall’esclusione di una delle due dai processi decisionali. Dopo anni in cui si è creduto, a torto, che la tecnologia da sola potesse sostituirsi a tutti i corpi intermedi della società, sta maturando oggi la consapevolezza che tecnologie sempre più importanti e complesse non possano prescindere dalla presenza “umana” per adattarsi alla mutevole complessità della vita quotidiana.
Malgrado i buoni propositi, la collaborazione tra umanisti e tecnici in azienda rimane tuttavia ferma allo stadio di auspicio. Non è raro, infatti, trovare aziende in cui una delle due figure tende a prevalere sull’altra, in ragione ora del maggior prestigio culturale degli umanisti, abituati fin dal liceo a considerare i tecnici come degli operai indistinguibili di una medesima catena di montaggio, ora della capacità “produttiva” dei tecnici, cui gli umanisti non sempre riescono a tenere il passo. Nel caso migliore, invece, le due anime dell’azienda tendono solitamente a ignorarsi, a fare come se gli altri fossero colleghi a tempo determinato e a cui rivolgersi solo in caso di estrema necessità.
Che cos’è un tecnico, che cos’è un umanista oggi? Ancor prima che nel confronto con epoche passate, è possibile distinguere le due figure professionali a partire dal linguaggio utilizzato. Narrativo, descrittivo, evocativo quello degli umanisti, mentre quello dei tecnici è un linguaggio “eseguibile”, che non descrive l’esistente ma fa accadere le cose. Un linguaggio che, a differenza di quello tradizionale, “produce esattamente gli effetti che sono scritti nei comandi”, per dirla con le parole del filosofo digitale Cosimo Accoto (“Il mondo dato”, Egea 2017). Ed è in questa assoluta diversità di linguaggio che si può misurare tutta la distanza che separa oggi le due figure professionali.
C’è bisogno di più tecnologia nella nostra umanità, e di una tecnologia che sia più umana possibile: nessun esperto, di nessuna specializzazione oggi può essere certo di avere dentro di sé la risposta a questo bisogno. Per questo è così importante trovare un canale di dialogo tra le due culture, nella consapevolezza che le figure ibride (che “masticano” codice, o che hanno fatto studi umanistici prima di prendere una laurea tecnica) saranno sempre minoritarie, e che la convivenza si reggerà sempre su un equilibrio instabile e dipendente dalla buona volontà delle singole persone.
Da dove cominciare? Umanisti e tecnici hanno bisogno di contaminarsi a vicenda, di partecipare gli uni ai processi decisionali su cui si basa il lavoro degli altri. Gli umanisti devono diventare voce in capitolo nel momento in cui si tratta di creare un nuovo servizio, di rinnovare un prodotto, di cambiare un processo. Sono gli unici in grado di opporre ai criteri di valutazione basati sull’efficienza, la velocità, la performance, dei criteri altrettanto validi e con cui ogni processo di innovazione deve fare i conti, prima o poi: il rispetto delle prerogative degli utenti, del benessere del singolo individuo, l’aderenza ai valori aziendali, l’attenzione ai possibili effetti sulla salute mentale e la stabilità sociale di tecnologie ancora imperfette. Essere umanisti in azienda, oggi, significa soprattutto essere dalla parte delle fasce più deboli dei consumatori e dei cittadini.
I tecnici, all’opposto, possono aiutare gli umanisti a liberarsi del fardello spesso insopportabile del passato, dei “padri nobili” di una disciplina, dell’arroganza di una cultura che pretende di esaurire ogni significato di ciò che è, è stato e sarà. In che modo? Portando dentro le riunioni degli umanisti, spesso e volentieri abbondanti di parole e povere di decisioni, una mentalità da “beta permanente” che possa servire da pretesto per tentare nuove strade, nuove strategie e nuovi approcci a problemi mai posti prima d’ora (i problemi che accompagnano la nascita di ogni nuova tecnologia, che troppo spesso negli ultimi anni gli uomini di cultura hanno sottovalutato o apertamente ignorato). I tecnici possono infine aiutare gli umanisti a misurare i risultati ottenuti, lasciando tuttavia a questi ultimi la facoltà di interpretare i dati e di decidere se farne o meno un punto di riferimento della propria strategia.
Più che nel ricorso a “project manager”, o altre figure di intermediazione che sono proliferate in questi primi anni di difficile convivenza, si potrebbe quindi sperimentare una condivisione di quei modelli di comportamento e ragionamento che costituiscono il punto di forza degli uni e degli altri, favorendo lo scambio tra i team anziché la loro rigida separazione. Questo, per ovviare ad alcune tra le maggiori difficoltà cui le aziende contemporanee vanno incontro: la mancanza di coraggio nell’innovare processi e prodotti ormai consolidati, e il suo opposto, la mancanza di qualsiasi limite nel processo di innovazione che non sia quello dell’efficienza e della velocità. In una fase storica in cui si assiste a un generale disincanto per le promesse universali della tecnologia, forse, la vera “disruption” sarà di quelle aziende che riescono a rispettare i limiti che loro stesse si sono date, pur quando avrebbero tutte le possibilità di infrangerli.
Per approfondire:
Cosimo Accoto, Il Mondo Dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale, Egea 2017.
Ellen Ullman, Accanto alla macchina. La mia vita nella Silicon Valley, Minimum Fax 2017.
Joe Morgan, I’m a Developer. I Won’t Teach My Kids to Code, and Neither Should You, Slate.com, 6 dicembre 2018.