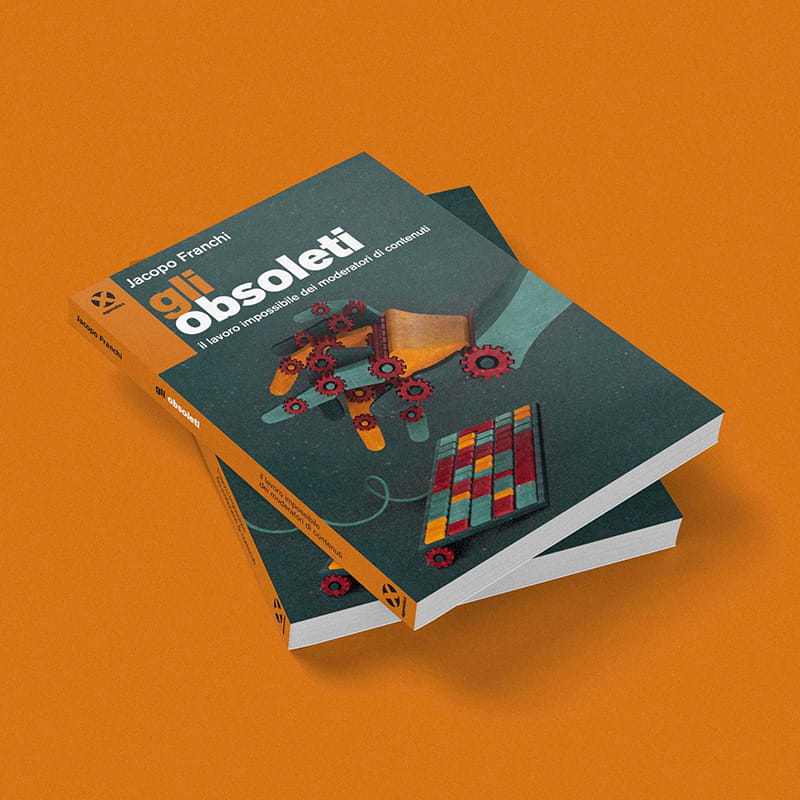Più che in eccesso, l’informazione in Rete è ridondante: siamo sicuri di voler rinunciare a insegnare agli studenti le nozioni di base, lasciandoli liberi di delegare la propria memoria a un supporto virtuale?
La scuola deve insegnare meno, per insegnare meglio? Secondo una corrente di pensiero sempre più diffusa, i giovani avrebbero a disposizione un numero di informazioni incredibilmente maggiore rispetto a quelle disponibili all’epoca dei loro genitori, e il compito degli insegnanti dovrebbe essere quello di educare al pensiero critico e alla riflessione anziché costringere gli studenti a memorizzare nozioni e conoscenze che potrebbero facilmente reperire online, nel momento del bisogno. Ma quali nozioni, e quali conoscenze sono disponibili gratuitamente e senza sforzo?
La magia del “Basta un clic”
Se è possibile oggi consultare gratuitamente cinque milioni e mezzo di voci di Wikipedia, “l’ultima cosa che può fare un insegnante è dare ai suoi allievi ulteriori informazioni. Ne hanno già troppe” scrive Yuval Noah Harari su La Domenica del Sole 24 Ore di domenica 26 agosto. “Oggi quasi tutti i sistemi scolastici del mondo impostano i loro programmi sull’accumulo di nozioni – prosegue lo storico israeliano – La gente invece ha bisogno di strumenti critici per interpretare le informazioni, per distinguere ciò che è importante da ciò che è irrilevante”.
Secondo lo storico, anche se vivessimo “in una qualsiasi cittadina messicana di provincia, e avessimo uno smartphone, potremmo trascorrere la maggior parte della vita a leggere Wikipedia, a guardare conferenze Ted, e a prendere parte a corsi online gratuiti”. Con ogni probabilità, tuttavia, non riusciremmo a farlo perché “se in tutto il mondo basta un clic per accedere ai resoconti più aggiornati su Aleppo o sullo scioglimento della calotta polare dell’Artico, ci sono anche una tale quantità di notizie contraddittorie che è difficile sapere a cosa credere”.
La riflessione di Noah Harari è solo l’ultima di una lunga serie, basata sulla diffusa convinzione che l’informazione sia ormai divenuta una risorsa illimitata, accessibile dovunque e in qualunque momento grazie agli smartphone, e che il problema principale sia piuttosto quello di distinguere le informazioni vere da quelle false, quelle importanti da quelle che sono solo rumore di fondo. Da un lato ci sono le “fake news”, dall’altro le notizie “verificate” che bisogna solo imparare a riconoscere.
Chi paga l’informazione?
Harari, purtroppo, non è il solo a credere che l’informazione condivisa in Rete coincida con la totalità della conoscenza umana, dallo “scioglimento dei ghiacciai” alle ultime notizie dal fronte militare. Purtroppo, se è vero che gli smartphone hanno reso un certo tipo di informazioni accessibili ovunque (le mappe, i numeri di telefono, il meteo…), è anche vero che la maggior parte delle informazioni di cui abbiamo bisogno dipendono dalla disponibilità di esperti, giornalisti e divulgatori a condividerle in Rete. Un lavoro mai come oggi necessario, e mai come oggi così scarsamente remunerato e riconosciuto, soprattutto online.
La produzione e distribuzione di informazione è un processo faticoso, complesso, e dispendioso dal punto di vista del tempo e delle energie mentali (e fisiche). Se dal punto di vista della distribuzione gli algoritmi di motori di ricerca e social media hanno dimostrato di poter sostituire il lavoro umano, pur con risultati molto discutibili e non trasparenti, la stessa cosa non può avvenire per la produzione di informazioni: gran parte dei “dati” che vengono prodotti sono in realtà la medesima variazione di un unico tema, una serie sterminata di articoli uguali l’uno all’altro, riassunti di altri riassunti, opinioni che si spacciano per fatti e fatti che non consentono di farsi alcuna opinione.
Più che di eccesso di informazione, dovremmo parlare di eccesso di ridondanza: delegare la memoria di fatti e nozioni alla Rete può essere una scelta azzardata, se la memoria stessa della Rete risulta lacunosa, casuale, arbitraria come quella umana.
Contro l’arroganza di chi si arroga il diritto di “insegnare agli altri a pensare” abbiamo oggi bisogno di docenti che sappiano mettere in discussione le proprie conoscenze e competenze, in alcuni casi risalenti a cinquant’anni fa, per aggiornarle e insegnare ai propri studenti a fare altrettanto, dubitando di tutto ciò che è gratuito, immediato, definitivo. L’obiettivo di ogni insegnante dovrebbe essere quello di stimolare gli studenti a diventare insegnanti di se stessi, per il resto della loro vita: dopo il diploma, la laurea, il master, dovranno vivere in un mondo che chiede loro di sapere tutto, senza dare loro il tempo di memorizzare alcunché. Distinguere il vero dal falso potrebbe risultare impossibile, se l’unico termine di paragone è la memoria che gli altri hanno scelto di condividere con noi.