All’estero, dove ho studiato e lavorato a lungo, ho provato anch’io la sensazione di essere un “cervello” e non solo un “consumatore”. E non ero più dotato degli altri. Semmai, per la prima volta nella mia vita ho sentito di poter pensare e mettere in pratica le mie idee nello spazio di una vita umana. E a quanto pare non ero l’unico.
La chiamano la “fuga dei cervelli”. Secondo il rapporto Eurispes 2012, il 60% dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni non esclude un progetto di vita all’estero. Giornalisti e politici si contendono le storie più toccanti per guadagnare la prima pagina dei giornali. C’è chi si dispera della partenza di questi giovani, e chi vede già il “posto libero” da occupare in loro assenza.
Come redattore di Cafebabel, dalla mia base di osservazione di Parigi ne ho viste tante, di quelle piccole lucine in movimento tra un bordo e l’altro del mondo. Le storie di successo le conosciamo tutti: il giovane che in Italia non trovava lavoro e ora si gode uno stipendio da 5.000 euro al mese; l’ex Erasmus che ha trovato l’amore all’estero e, per necessità, si è inventato un lavoro profittevole per rimanere vicino alla sua nuova compagna; il cameriere che ora è direttore di un ristorante in una famosa cittadina tedesca.
Da giornalista, mi interessano molto di più le storie andate a male. Quelle di chi è tornato in Italia. Eppure anche lui era partito sulle rotte dei “vincenti”, con una malcelata speranza di non fare più ritorno.
“Partire” è un verbo che accomuna destini diversi. Evoca valige strapiene, treni nella notte, sms di “benvenuto” da parte degli operatori telefonici e sorrisi di nonne che forse non si vedranno più. Si parte da soli, in compagnia, sotto l’egida dei grandi pensatori del passato: Erasmus, Leonardo, Socrates, come se oltrepassare le frontiere fosse il contrappasso necessario per afferrare la filosofia dei nostri giorni.
L’economia globalizzata, i trasporti ad alta velocità, l’euro, i traduttori simultanei: sembra che tutto sia stato creato apposta per aprirci la via.
Qualcosa è stato fatto per richiamare questa popolazione di emigranti “per necessità”, con la legge “controesodo” (238/2010) che concede sgravi fiscali ai laureati che hanno lavorato all’estero almeno due anni, nati dopo il 1969. Ogni tanto emergono singolari iniziative, come quella di MeeTalents, lanciata a Milano lo scorso 20 dicembre. Ma chi ritorna vorrebbe anche rendersi utile per il suo Paese. Trovare condizioni di lavoro migliori di quelle di cui era andato alla ricerca all’estero. Mettere in pratica le conoscenze raccolte in luoghi lontani. Sperimentare quello che in Italia non c’è ancora. Gli sgravi fiscali, da soli, assomigliano tanto a un rimborso spese arrivato con qualche anno di ritardo.
E quelli che partono per sempre? Come l’acqua, di loro non si ha nessun ricordo. Tranne i familiari e qualche amico fedele nel tempo, le istituzioni e gli uomini che lavorano per l’interesse pubblico riescono solo ad aggiungere un segno “meno” nelle statistiche della comunità. Non sono previste valutazioni qualitative. Gli uffici di orientamento per l’estero si limitano a raccogliere informazioni, proposte di lavoro, lettere di motivazione e curriculum. Non hanno né il tempo, né i mezzi, per seguire tutti quelli che partono “altrove”. Eppure, quanto lavoro ci sarebbe da fare!
I “cervelli” in fuga, ma anche i comuni mortali, si sono sentiti incompresi, lasciati a sé stessi, persi nell’alto mare aperto senza che dietro ci fosse una luce che permettesse loro di orientarsi e ambientarsi più facilmente nella nuova destinazione.
Le deficienze degli organi universitari e istituzionali nei riguardi dei giovani che emigrano – anche solo per un anno – sono all’ordine del giorno. Malgrado tutti gli sforzi fatti, ancora oggi la buona riuscita di una esperienza all’estero ricade tutta sulle spalle del prescelto.
Gli Erasmus per primi devono affrontare la loro parte di incognito, dal momento che non esiste un database aggiornato delle esperienze di chi è partito prima verso una determinata destinazione, non ci sono posti riservati per loro negli alloggi universitari, non è garantito un collegamento continuo con l’università di partenza.
Come Erasmo da Rotterdam, il programma richiede una buona dose di follia per essere seguito fino in fondo.
Gli “uffici internazionali” delle Università, che dovrebbero accompagnare ogni singolo studente nella sua partenza per l’estero, spesso si limitano a un semplice lavoro di convalida dei documenti. Non sono attrezzati a monitorare il lavoro dello studente, a riceverne le critiche e i suggerimenti, a compilare un semplice database online di testimonianze che permetterebbe a chi viene dopo di orientarsi con molta più facilità nell’ambiente straniero.
Nelle università pubbliche, l’esiguità dell’importo delle borse di studio e la pigrizia mentale dei professori hanno portato negli anni gli annunci per i bandi Erasmus a una posizione di secondo piano. Bisogna andarli a scovare, grazie alla propria curiosità e alla pulce nell’orecchio di qualcuno che è già partito. Sottoscala bui e aule dimenticate sono i luoghi dove le informazioni essenziali per partire vengono svelati. Le associazioni di studenti qualche volta aiutano, qualche altra sono semplicemente dei contenitori senza contenuto. Quanto sia difficile, infatti, mettere insieme le conoscenze e le competenze di più persone che sono “partite” all’avventura lo vedremo più avanti.
Si vuole, contro ogni logica performativa, mantenere un alone di avventura e mistero attorno al nome di Erasmus, tanto inutile quanto dannoso per la buona riuscita del percorso formativo dei ragazzi. Che al ritorno devono spesso girare tra dieci professori prima di trovare qualcuno disposto a tradurre le votazioni prese all’estero in trentesimi, e convalidare gli esami.
Finiti gli studi, si può fare un Erasmus “per lavoratori”. La bella compagnia è ormai scomparsa, le mille speranze e prospettive si sono ridotte a una sola: è il caso del programma Leonardo, che finanzia un periodo di stage formativo, in una determinata disciplina, in un altro Paese. Aumentano i soldi a disposizione, che arrivano a coprire vitto, alloggio e buona parte degli extra. Nell’ambiente si vocifera che fino al 60% di quanti effettuano lo stage vengono poi assunti dall’impresa straniera che li ha accolti. Ma le statistiche sono ancora una volta incerte.
Dopo 25 anni dalla nascita di Erasmus, non ci sono ancora studi approfonditi in grado di stabilire il suo impatto sulle diverse società europee. Nella coscienza collettiva, gli Erasmus rimangono un’élite intellettuale inoffensiva e perennemente scontenta dell’esistenza sedentaria. La prima “eurogenerazione” sta assumendo limiti temporali anomali: i ragazzi che partono oggi potrebbero essere i figli di quei 3.244 studenti che nel 1987 hanno dato il via alle danze. Ma tutti, indistintamente, sono una minoranza esigua all’interno di un continente ancora rigidamente suddiviso per nazionalità e lingue.
Sulla poesia dell’avventura abbiamo visto scorrere fiumi di pagine. Al momento di prendere “quel” treno, tutti gli emigrati sono gli stessi. Chi andrà all’estero per uno stage, chi per fare il lavapiatti, chi per lavorare in uno studio di avvocati a Bruxelles, chi ancora non sa bene cosa, tutti risplendono di quella particolare luce che ci illumina quando siamo all’alba di un grande cambiamento. La retorica si spreca, in queste occasioni. I saluti di persone che non vedevamo da una vita diventano il riconoscimento dello sforzo supremo. “Oh madonnina chi l’avrebbe mai detto – cantava un noto cantatutore, scomparso il 1° marzo 2012 – vado a incontrare la vita”.
In un momento di profonda crisi, economica e sociale, l’unica soluzione per non sprecare gli anni migliori della propria vita sembra essere quella di muoversi. Non rimanere fermi, fare esperienze, controllare se il mondo ha fatto un’altra giravolta. Lo consigliano tutti, lo provano in pochi. Perché è solo rimanendo fermi che ci si rende conto di quanto sia spericolata la velocità con cui si prende il volo.
Le immagini entusiaste vengono meno, invece, quando arriva il momento del ritorno. Ci si sente come Usain Bolt quando arriva alla fine della corsa. I muscoli tesi nello sforzo si sgonfiano come airbag che hanno esaurito il loro compito. E non c’è nessun giudice di gara a dirci se abbiamo vinto o perso. “Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, con il morto sorriso dell’uomo che ha compreso”: Cesare Pavese ha già trovato per noi l’espressione che contraddistingue tutti coloro che, come il protagonista della sua poesia, fanno ritorno alle “spiagge di un tempo”. Anch’io sono stato fra quelli, per ben due volte.
Da un giorno all’altro, sapori, colori, odori e suoni che durante la vita all’estero erano diventati famigliari si perdono tutti dentro all’asettico collegamento a Internet. Indirizzi mail, amicizie vere o presunte via Facebook, sms di “buon viaggio di ritorno” sono il bagaglio imponderabile che portiamo a casa. Hanno preso il posto dei vestiti e dei generi di prima necessità che dovranno sostenerci nei primi mesi della partenza “all’incontrario”. Promesse di viaggi futuri sono il debole paracadute con cui ci prepariamo ad atterrare.
Non ci sono più volti nuovi che ci guardano con curiosità animalesca. La nostra storia la conoscono tutti. Anche se una parte di quella deve ancora essere assimilata alla nostra biografia. Essere italiani, giovani, sorridenti, loquaci, istrionici, autoironici non è più una particolarità che ci apre le porte di infinite compagnie.
Siamo tornati ad essere italiani in Italia, e perciò “normali”, in una società che non sa che farsene della diversità in entrata. Le domande sulle esperienze in paesi lontani si riducono a un “è andata bene? Hai imparato la lingua?”, quando non al più umiliante “perché sei tornato?”. Qualcosa si è rotto, nei rapporti con l’ambiente di origine. Ci si accorge di quanto fosse limitata, angusta e falsa la vita che si è sperimentata per anni.
Il “ritornato” deve costruirsi da solo la sua storia di successo. Fare gli esercizi allo specchio ogni giorno, per convincersi che davvero ha vissuto all’estero. Che esiste un posto nel mondo dove si esce di casa a 18 anni. E gli studi finiscono prima, per dare a tutti la possibilità di sperimentare la soluzione lavorativa più adatta. A inventarsi qualcosa di nuovo, prima che sia troppo tardi. E le borse di studio bastano a dormire sonni tranquilli tra una lezione e l’altra. Un luogo dove ai giovani è concesso un minimo salariale per poter vivere autonomamente. Dove a 25 anni si è considerati dei “giovani uomini” (dal francese “jeunes hommes”) in divenire. E le persone di origini diverse possono riconoscersi in una stessa società.
L’Italia dei compartimenti stagni, delle paure verso il diverso, delle lingue imparate a malapena, dei laureati in fuga e degli immigrati respinti appare per la prima volta in tutta la sua desolante povertà.
Si torna a un Paese che è cambiato più lentamente di noi. Visto da lontano, non sembrava neanche male. Non si differenziava da qualunque altro posto nel mondo. Erano, semmai, gli amici stranieri che ce lo vantavano come meraviglioso, ci raccontavano i loro viaggi tra Napoli, Firenze e Venezia. E, attraverso i loro occhi di turisti in vacanza, andavamo orgogliosi di quella terra che non aveva saputo darci null’altro che un biglietto di sola andata in classe economica. Buffa la vita, a volte.
Parlarne, con chi ci conosce, fa bene. Sempre, comunque, si prova la sensazione di vivere in un mondo di ciechi che giurano di vederci benissimo.
Quello che manca, alla fine, lo si riconosce dopo molti mesi di rabbiosa solitudine. Non sono le feste, gli incontri casuali, le scoperte di nuove città, a rendere unica quella particolare esperienza per l’estero. Di queste cose l’Italia è ricca. Le imprese amorose e i viaggi degli Erasmus non si discostano molto da quelli che si potrebbero fare in una qualunque vacanza in un villaggio turistico, o in Interrail. A mancare, è un altro tipo di possibilità di contatto.
Si ritrovano in bilico tra due culture che hanno smesso di comunicare da tempo. Sospesi fra il soffio dell’infinito, delle grandi distanze, delle possibilità concrete e tutte da scoprire, e i volti e i paesaggi che un tempo delimitavano il mondo. E dai quali non è così semplice staccarsi, una volta per tutte: “il peggio è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi conoscono, e dev’essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada”, era la triste costatazione di Mena, personaggio dei “Malavoglia” di Giovanni Verga.
Ciò che gli Erasmus – e a seguire tutti gli altri avventurieri dei nostri tempi – non trovano in Italia è quella diversità di lingue, culture, storie e punti di vista che all’estero li aveva inglobati dentro di sé. Tornano, e sono come delle mosche bianche. Più emarginati degli emarginati. Sentono che tutti gli sforzi compiuti per integrarsi all’estero sono stati resi vani dal ritorno. E che tutti gli sforzi che dovranno fare per integrarsi nuovamente saranno resi più difficili da una società che non tollera la loro nuova diversità. Perché non ci possono fare niente: sono bastati pochi mesi per acquisire una personalità nuova, uno sguardo maturo, un orizzonte più esteso rispetto a quello a cui media e università li avevano abituati.
Le caratteristiche che fuori dall’Italia li rendevano capaci di imporsi in un ambiente sconosciuto – la loro diversità, un valore che risalta solo quando messo a confronto con le diversità altrui – al ritorno sono le stesse che li condannano ai margini di una società che si vuole appiattita su rappresentazioni stereotipate. La visione globale che hanno assunto diventa un impaccio, in un Paese dove le notizie seguono gli umori del politico del momento, le fluttuazioni dello spread, i gossip della Riviera. “A che servono gli occhi che vedono lontano – chiedeva Nietzche, in “Così parlò Zarathustra” – bramosi di veder lontano?”.
Non potersi confrontare con il nuovo e il diverso, non fare continuamente esperienza di storie e culture differenti, non essere messi in forse – nel loro rassicurante status di “italiani in Italia” – equivale per molti di loro a una momentanea morte. Tornano, ed è come se scomparissero dai radar di chi li conosce da una vita. Rifiutano la compagnia dei parenti, passano il tempo davanti al computer, o a guardare un punto dell’orizzonte lontano che solo loro riescono a distinguere con precisione. Il più delle volte, sembrano solo depressi.
A poco a poco si fa strada un senso di fallimento esistenziale. Sentono di aver perso tempo, in tutta quella prima parte della loro vita passata lontano dal mondo. Le storie della crisi, gli esempi di chi ha superato le ultime resistenze, è partito e all’estero sta avendo successo (così si dice), concorrono a disegnare un orizzonte degli eventi funereo. I voli low cost e i treni ad alta velocità creano uno sfasamento spaziale/temporale nelle distanze percepite dai luoghi delle recenti avventure, e quelle reali.
Basterebbe poco – si dicono – un po’ di coraggio rimasto, una valigia più leggera, e potrebbero tornare in quel luogo dove tutto sembrava avere un senso.
Qualche viaggio estemporaneo all’estero, la visita di un amico conosciuto in luoghi lontani aiutano a superare i momenti più neri. Con il passare dei giorni si recupera un poco di colorito. Le abitudini di un tempo tornano a farsi sentire. Si cerca un compromesso tra il nuovo e il vecchio mondo. I più espansivi provano a fare proseliti, convincendo i compagni a partire all’avventura sulle loro tracce. Internet rimescola il giro delle amicizie, e ci si trova a scambiare lunghe corrispondenze con persone che si erano conosciute solo negli ultimi giorni di permanenza all’estero, e ad accettare i silenzi di chi sembrava legato a noi per la vita.
Come si può notare, la retorica si trova anche nei racconti di chi è tornato a casa. La sfida non è più quella di conquistare un nuovo mondo, ma di trovare un nuovo posto nel vecchio. Che, per un attimo, avevamo sperato di lasciare per sempre.
Quello che rimane, alla fine, è pur sempre un racconto solitario e che non trova una continuità con altri. Il “rischio d’impresa” di chi decide di investire su sé stesso non porta ancora a un racconto condiviso, a una storia esemplare che possa generare nuovi esperimenti.
Le strategie di sopravvivenza, di adattamento, lo scambio delle conoscenze e la loro trasmissione alla società sono lasciate al caso, all’iniziativa del singolo e a pochi, sparuti testi letterari trovati sulle bancarelle di seconda mano.
È venuto il momento che il mondo accademico, della ricerca, e gli uffici di selezione del personale comincino ad elaborare criteri oggettivi di valutazione di chi ha un’esperienza internazionale alle spalle. Che venga messa nero su bianco la quantità di risorse sprecata nell’oblio di questa generazione “in fuga”.
Abbiamo bisogno di casi di studio approfonditi, di una letteratura scientifica e fantastica in grado di delineare i contorni dei nuovi abitanti dell’Europa e del mondo. Facendo uscire una volta per tutte l’emigrante dai confini del sogno, dell’invidia e dell’indifferenza, per accogliere finalmente quello che ha da portarci.
Gli Erasmus di oggi ricordano da lontano i mercanti di spezie orientali del Medioevo: portano con sé un carico preziosissimo – la conoscenza e la capacità di interagire con le altre culture, appresa sul campo – ma devono rischiare la pelle pur di trasportarlo intatto fino in patria e diffonderlo tra la gente.
Il fuggitivo è sempre precipitoso, irrazionale, impreparato ad affrontare tutti gli imprevisti. Come quello di un ritorno non voluto, di una fase di riadattamento che potrebbe annullare gran parte delle conoscenze che si sono accumulate nei mesi precedenti.
Gli italiani in fuga sono ancora solo un numero nelle statistiche, e spesso nemmeno quello. Scompaiono, letteralmente, dall’orizzonte delle promesse elettorali di questo o quel candidato alla presidenza del Consiglio. E al ritorno, è come se fossero degli immigrati in arrivo da un paese e da una cultura sconosciuta. Qualche volta troppo avanzata, per poter essere compresa. Nella stessa indifferenza in cui sono partiti, così tornano a casa.
Il giovane che parte per l’estero non deve per forza sentirsi in “fuga” da qualcosa. Trovo ridicolo che, decenni dopo la fine delle frontiere, ancora si faccia differenza tra migrazione interna e esterna, quando si parla di Italia. I giovani di oggi sfruttano uno spazio che i loro padri sono riusciti a mettere al riparo dalle guerre per più di sessant’anni. Se cercano lavoro in un ambiente linguistico diverso, non smettono di essere italiani e di avere dei diritti da rivendicare anche in questo Paese.
Jacopo Franchi




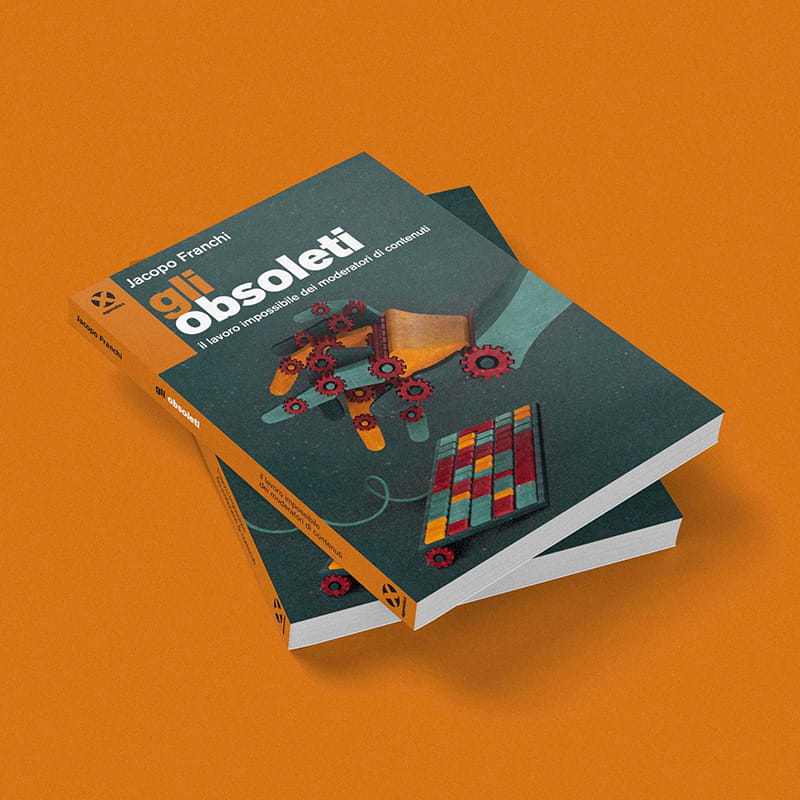


L’ha ribloggato su francescoveronese.